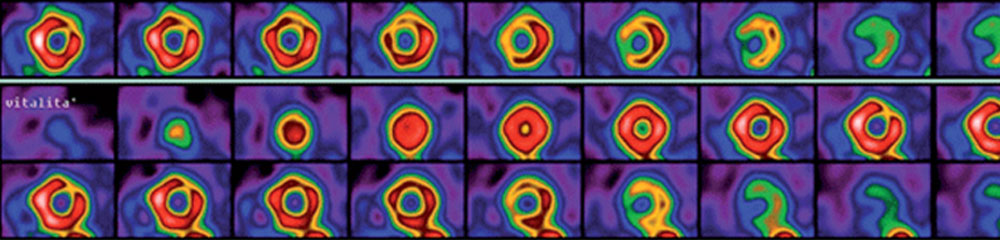Endowiki: aggiornamento continuo di endocrinologia
Per tutti gli operatori di endocrinologia: lo stato dell'arte su clinica e terapia.
Uno strumento semplice e fruibile da tutti coloro che intendono essere sempre aggiornati, promosso dai migliori operatori del settore.
News
Farmaci
Oggetto di questa sezione sono i concetti generali (meccanismi d’azione, indicazioni, contro-indicazioni, effetti collaterali, prescrivibilità) sui farmaci impiegati nelle diverse patologie, mentre i risultati delle terapie farmacologiche sono illustrati nei capitoli relativi alle diverse patologie.
Farmaci per le patologie ipofisarie
Farmaci per le patologie tiroidee
Farmaci per le patologie paratiroidee
Farmaci per le patologie ossee
Aspetti generali di terapia farmacologica
Oggetto di tutta questa sezione sono i concetti generali (meccanismi d’azione, indicazioni, contro-indicazioni, effetti collaterali, prescrivibilità) sui farmaci impiegati nelle diverse patologie, mentre i risultati delle terapie farmacologiche sono illustrati nei capitoli relativi alle diverse patologie.
Overview sui concetti generali di farmacocinetica e farmacodinamica
Overview sui concetti generali di farmacocinetica e farmacodinamica
Raffaele Volpe
Endocrinologia, Ospedale Cardarelli, Napoli
Farmacocinetica
La farmacocinetica descrive i processi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione di un farmaco (ADME).
L’assorbimento è il processo tramite cui il farmaco penetra nell’organismo (sangue) dal sito di esposizione.
La distribuzione è il processo di passaggio dal sangue ai vari organi e tessuti.
Il metabolismo di un farmaco è l’insieme delle trasformazioni chimiche che la molecola subisce all’interno dell’organismo, principalmente ad opera di enzimi. I derivati metabolizzati del farmaco (metaboliti) sono molecole con caratteristiche chimiche e farmaco-tossicologiche diverse dal composto di partenza. In genere, i metaboliti sono privi di attività farmacologica. Il metabolismo è quindi una modalità di ‘eliminazione’ del farmaco prevalentemente epatica (1).
Diversi farmaci, tuttavia, hanno metaboliti ‘attivi’, dotati cioè di attività farmacologica simile a quella del farmaco ‘madre’. Inoltre, alcuni farmaci sono in realtà pro-farmaci’: sono cioè farmacologicamente inattivi, ma vengono trasformati in composti attivi dal metabolismo. In alcuni casi, i metaboliti dei farmaci sono tossici e possono essere ulteriormente metabolizzati, con formazione di composti non tossici (detossificazione)(2).
Il metabolismo ha una ‘logica’: trasformare la molecola in modo che possa essere facilmente escreta per via renale o biliare. Le sostanze lipofile sono escrete più lentamente di quelle idrofile perché sono più facilmente riassorbite nel tubulo renale (o nell’intestino in caso di eliminazione biliare) e si accumulano nel tessuto adiposo. Dato che le molecole idrofile sono eliminate più rapidamente di quelle lipofile, il metabolismo consiste principalmente nella trasformazione di molecole lipofile in molecole idrofile (3).
Il fegato è l’organo nel quale avvengono le maggiori biotrasformazioni. Queste coinvolgono due tipi di reazioni biochimiche, spesso consequenziali, che vanno sotto il nome di reazioni di prima e seconda fase, non sintetiche e sintetiche. Le reazioni di fase I portano in genere all’introduzione nella molecola di gruppi funzionali come -OH, -NH2, -COOH (reazioni di funzionalizzazione). Nelle reazioni di fase II, molecole endogene fortemente polari (es. acido glucuronico) vengono legate ai gruppi funzionali inseriti durante la fase I (reazioni di coniugazione) (2).
A livello individuale, la capacità metabolizzante è determinata, oltre che da fattori genetici, anche da fattori ambientali: la quantità di enzima presente può essere infatti aumentata da alcune sostanze (induzione enzimatica). La velocità di metabolismo è il fattore più importante nel determinare la variabilità farmacocinetica inter-individuale. Gli altri processi influenzanti la farmacocinetica (assorbimento, legame con le proteine plasmatiche, distribuzione, escrezione renale) sono pressoché costanti da individuo a individuo; si hanno variazioni di questi processi solo in condizioni patologiche (in particolare, insufficienza renale) (3).
Le interazioni tra farmaci più rilevanti sono dovute ad interazione a livello del metabolismo (induzione, inibizione, competizione)(1).
L’eliminazione di un farmaco dipende da tutti gli altri processi farmacocinetici. Tre fattori giocano un ruolo fondamentale: il legame alle proteine plasmatiche, la ionizzazione in funzione del pH e la biotrasformazione (2).
Vi sono modelli che descrivono graficamente la farmacocinetica e parametri che permettono di prevedere e di studiare il comportamento cinetico dei farmaci (2):
- la biodisponibilità esprime la frazione del principio attivo che raggiunge “inalterata” il circolo generale e la velocità con cui lo raggiunge;
- l’emivita o tempo di dimezzamento è il tempo necessario affinchè un farmaco passi da una concentrazione ematica X a X/2;
- il volume apparente di distribuzione rappresenta il volume in cui tutto il farmaco si distribuisce in modo uniforme per dare la concentrazione plasmatica osservata;
- la clearance rappresenta il volume plasmatico che viene depurato dal farmaco nell’unità di tempo.
Farmacodinamica
La farmacodinamica studia gli effetti biochimici e funzionali del farmaco e il suo meccanismo d’azione, proponendosi di identificare i siti di azione dei farmaci e caratterizzare la sequenza completa farmaco-effetto. Inoltre studia la relazione tra la dose del farmaco somministrato e la risposta funzionale indotta (1).
Gli effetti terapeutici e tossici indotti dal farmaco dipendono dall’interazione dello stesso con il sito d’azione o bersaglio molecolare (responsabile della selettività dell’azione) che può essere: recettore, enzima, canale ionico, trasportatore, acido nucleico (1).
I recettori trasducono i segnali extra-cellulari in segnali intra-cellulari e provocano risposte biologiche dovute alle loro modifiche chimico-fisiche. I recettori possono essere di superficie (canali ionici azionati dal ligando, recettori accoppiati a proteine G, recettori legati a enzimi) o intra-cellulari (il farmaco deve essere liposolubile per penetrare nella cellula, raggiungere il recettore, legarsi ad esso e migrare a livello nucleare)(2).
L’interazione tra farmaco e recettore è mediata da legami deboli e segue la legge dell’azione di massa: aumenta all’aumentare della dose e l’effetto è proporzionale al numero dei recettori occupati. Il legame è comunque saturabile e reversibile. L’interazione farmaco-recettore è regolata dall’affinità del farmaco per il recettore (indice della sua potenza) e dall’attività intrinseca del farmaco di induzione di una risposta biologica (indice di efficacia)(3).
La dose efficace media ED50 è la dose o concentrazione di farmaco necessaria per produrre una risposta pari al 50% di quella massima.
La potenza di un farmaco è la misura della dose di farmaco necessaria per provocare una risposta biologica e dipende dalla sua affinità recettoriale. La potenza di un farmaco determina la dose da somministrare (3).
In base alla risposta biologica generata dal legame al recettore, equivalente o non equivalente a quella del ligando endogeno, i farmaci si definiscono rispettivamente agonisti o antagonisti del recettore (competitivi o non competitivi)(2).
Il numero dei recettori e la sensibilità possono variare nel tempo, dando origine a fenomeni di desensibilizzazione (down-regulation) e più raramente di ipersensibilizzazione (up-regulation). Nel primo caso vi è una diminuzione dei recettori dovuta all’esposizione prolungata al farmaco, per cui si deve aumentare la dose del farmaco (tolleranza al farmaco) e nel secondo caso vi è un aumento del numero dei recettori con possibilità di fenomeni di rimbalzo alla sospensione (2).
Bibliografia
- Howland RD, Mycek MJ. Le basi della farmacologia. Zanichelli 2007.
- Rossi F, Cuomo V, Riccardi C. Farmacologia per le professioni sanitarie. Edizioni Minerva Medica 2011.
- Clementi F, Fumagalli G. Farmacologia generale e molecolare. UTET 2000.
Ricettazione
Enrica Ciccarelli
SS Patologie Endocrino-Metaboliche, Ospedale Martini, Torino
Al fine di garantire la massima sicurezza sull'utilizzo del farmaco, l'accesso del cittadino a questo bene non è libero, ma regolato da speciali norme che escludono l'utilizzo delle leggi generali del commercio, riservando esclusivamente al farmacista la dispensazione al pubblico. La prescrizione medica assume pertanto il significato di un'autorizzazione scritta da parte del medico che consente la consegna del medicinale al paziente da parte del farmacista, unica figura autorizzata a effettuarla. La ricetta è pertanto principalmente espressione dell'intervento medico, da cui conseguono il momento diagnostico e la conseguente scelta terapeutica. Nell'ambito del SSN la ricetta medica rappresenta anche un atto di autorizzazione del diritto da parte del paziente alla prestazione farmaceutica in regime assistenziale. Nel tempo la prescrizione medica ha assunto maggiormente il significato di un atto amministrativo con rilevanza economica sempre maggiore.
L'accesso del pubblico ai farmaci è disciplinato da 3 diversi regimi:
- ricetta medica per cosiddetti farmaci etici, che possono essere dispensabili in regime assistenziale e non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari;
- senza ricetta e su consiglio del farmacista per i farmaci senza prescrizione (SP), classificati come etici;
- senza ricetta e su richiesta diretta del paziente per le specialità da banco (OTC: over the counter), pubblicizzabili ed escluse dal SSN.
Sotto il profilo amministrativo la prescrizione medica si articola in varie forme che realizzano livelli diversi di sicurezza e di tutela: la ricetta ripetibile, la ricetta non ripetibile, la ricetta speciale e la ricetta limitativa.
La ricetta ripetibile è la forma più comune di prescrizione, applicabile per esempio ad anti-ipertensivi, antibiotici, tiroxina, estro-progestinici, ecc. La legge impone al medico l'obbligo di firmare e datare la prescrizione; è pertanto fondamentale l'identificazione del medico mediante l'uso di carta intestata o di un timbro in chiaro, soprattutto nei casi di utilizzo di ricettari intestati a ospedali, cliniche ecc, o di modelli del SSN. La validità nel tempo è fissata in tre mesi e in questo arco temporale per 5 volte per utilizzo nella stessa farmacia. Il medico ha facoltà di variare questi termini, con esplicita dichiarazione in calce alla ricetta. Se il numero di unità prescritte dal medico è superiore all'unità, il farmacista potrà dispensare soltanto la quantità indicata. La ricetta ripetibile resta di proprietà del paziente e deve essere a lui restituita, con l'apposizione di data prezzo e timbro da parte del farmacista in ogni spedizione. La mancanza di indicazione del dosaggio comporterà la dispensazione di quello minore da parte del farmacista. Il medico è in grado di conoscere l'obbligo di prescrizione con ricetta tramite la scheda tecnica del farmaco.
La ricetta non ripetibile è obbligatoria per tutti i farmaci con rischi potenziali di tossicità, assuefazione o possibilità di abuso (es. ipnotici, DHEAs). La ricetta non ripetibile è valida solo tre mesi e può essere presentata in farmacia solo una volta per la spedizione. Il medico non ha alcuna possibilità discrezionale di variazione e pertanto le eventuali dichiarazioni in calce alla ricetta vengono disattese dal farmacista perchè illegittime. Questa categoria di farmaci è riconoscibile perchè riporta sulla confezione la dicitura “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da utilizzarsi una sola volta”.
La ricetta speciale disciplina l'accesso del pubblico ai farmaci (sostanze psicotrope e stupefacenti) che necessitano di particolari e rigorosi controlli per la loro capacità di indurre dipendenza. La ricetta speciale viene distribuita dall'Ordine Professionale competente.
La ricetta limitativa è quella il cui utilizzo è limitato ad alcuni medici o a particolari ambienti. Rientrano in questa categoria tre tipologie di farmaco:
- vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti (es. pegvisomant). Sulla loro confezione deve essere riportata l'indicazione del tipo di struttura o specialista autorizzato alla prescrizione;
- non vendibili al pubblico, il cui impiego è consentito solo in ambiente ospedaliero per caratteristiche farmacologiche, innovatività, modalità di somministrazione o motivi di tutela della salute pubblica (es. diazossido). Presentano sulla confezione l'indicazione al tipo di struttura o specialista autorizzato alla prescrizione;
- non vendibili al pubblico, utilizzabili dallo specialista durante la visita ambulatoriale (es. denosumab). Riportano sulla confezione: uso riservato a (specialista autorizzato), vietata la vendita al pubblico.
La ricettazione è avvenuta fino a oggi in forma cartacea, ma è in via di organizzazione un sistema in formato elettronico. Il medico, dopo avere ricevuto i moduli telematici dagli enti preposti (ASL, Aziende Ospedaliere o altri su indicazione delle Regioni), compila la ricetta elettronica, inviando on line i dati alla farmacia e rilasciando copia cartacea pro-memoria al paziente. Al momento della compilazione il medico invierà i dati al SAC (Centro di Accoglienza Centrale) o al SAR (Centro di Accoglienza Regionale per le regioni già organizzate) comprensivi di numero di ricetta elettronica (NRE), codice fiscale del paziente ed eventuale esenzione. Al farmacista basterà controllare on line la prescrizione, l'identificazione tramite la tessera elettronica e consegnare il farmaco al paziente.
Va ricordata una particolare modalità di compensazione finanziaria inter-regionale dei farmaci somministrati in regime diverso dal ricovero, denominata File F. Nato inizialmente come semplice strumento di compensazione di farmaci non rimborsati tramite le tariffe di ricovero e ambulatoriali, il File F è stato utilizzato da molte Regioni come strumento di compensazione tra le diverse Aziende Sanitarie Locali (ASL) in una stessa Regione o tra Aziende Ospedaliere e ASL. Possono essere rimborsati con questa procedura i farmaci non somministrati in regime di ricovero, in particolare: farmaci innovativi in fascia H, farmaci somministrati in ambulatorio, farmaci in duplice via di distribuzione compresi nel prontuario ospedaliero, anti-blastici, iposensibilizzanti e galenici, farmaci non registrati compresi nella Legge 648/1996, farmaci somministrati a stranieri con codice STP, farmaci per malattie rare, farmaci distribuiti direttamente limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, farmaci distribuiti dagli istituti penitenziari, farmaci distribuiti direttamente dalle ASL.